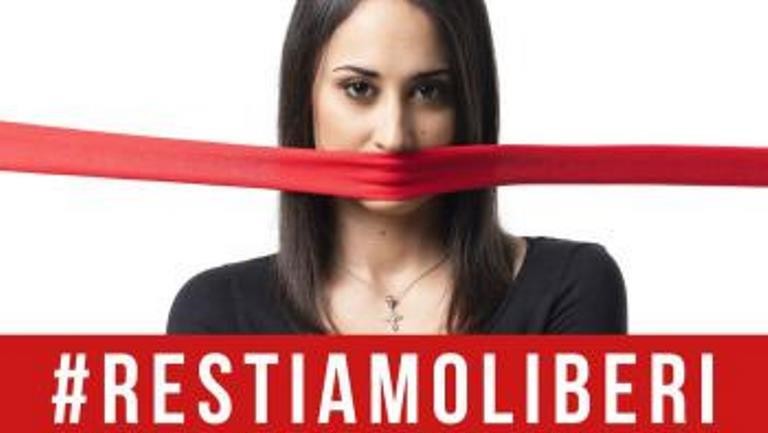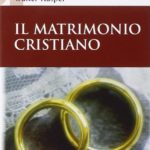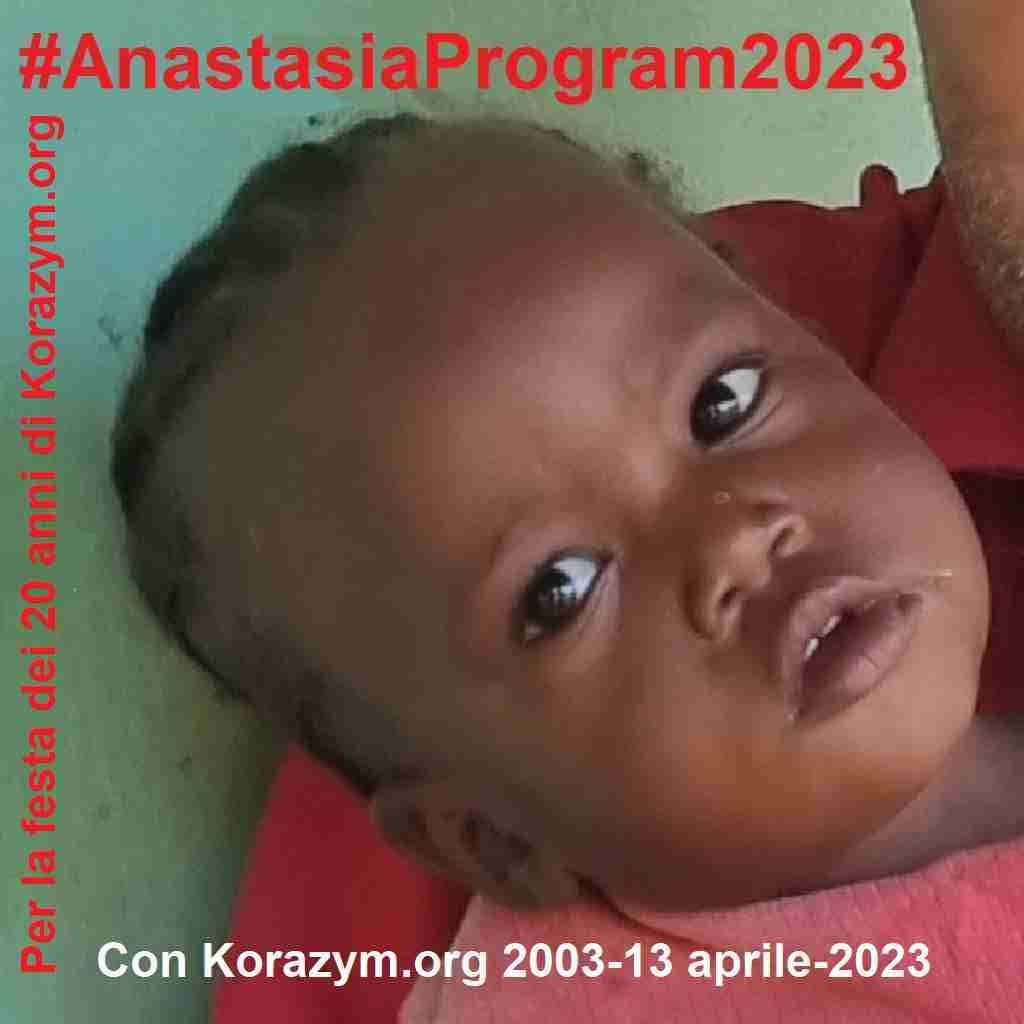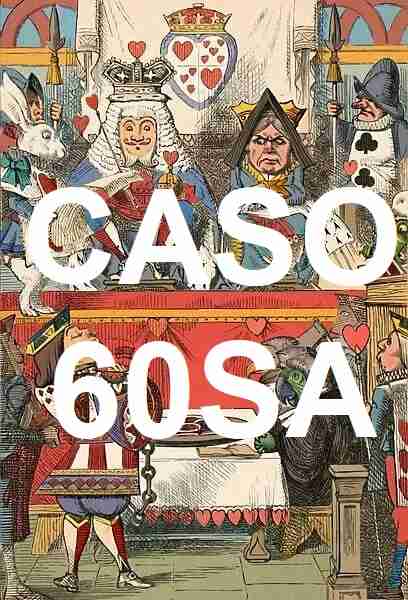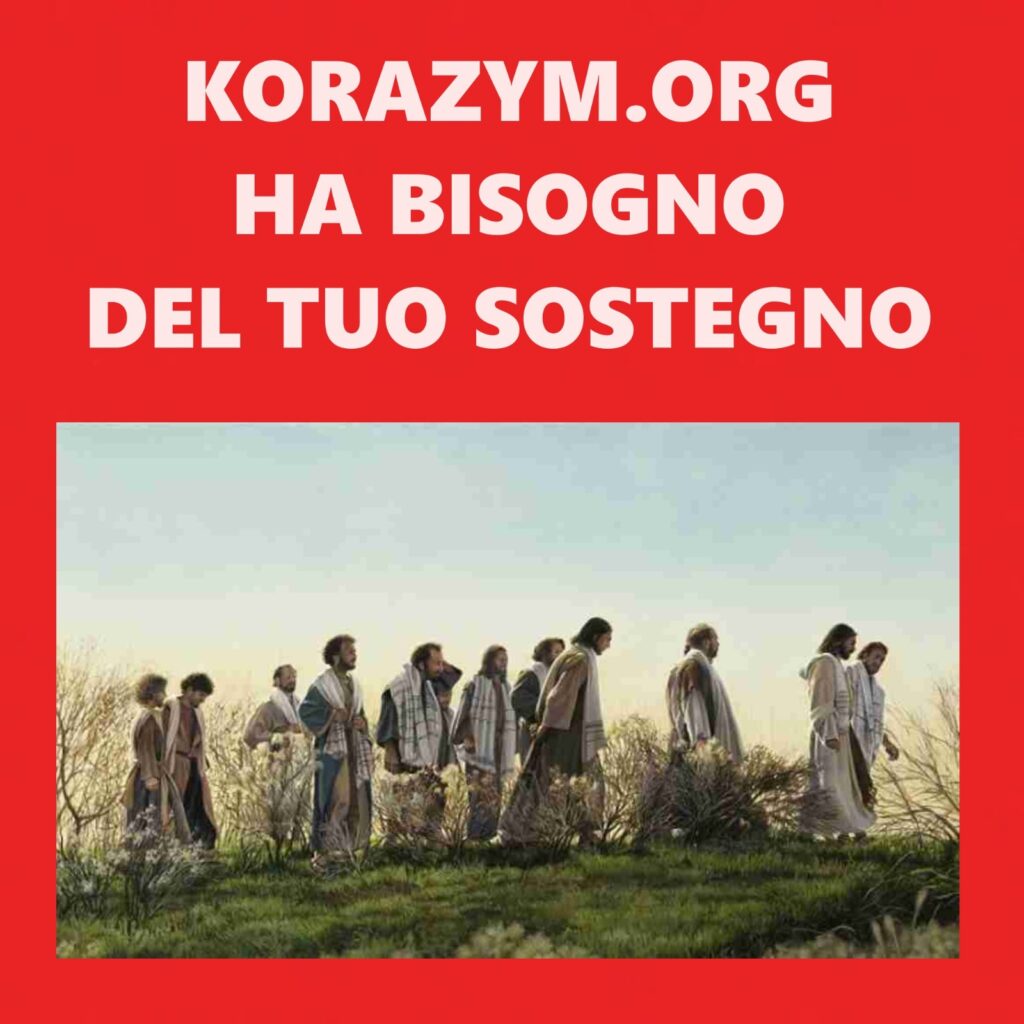Papa Francesco e il governo della Chiesa

[Korazym.org/Blog dell’Editore, 31.03.2025 – Andrea Gagliarducci] – Papa Francesco è tornato in Vaticano da poco più di una settimana, con almeno altre sette di convalescenza da trascorrere, durante le quali i suoi medici gli hanno prescritto di mantenere un programma rilassato e un carico di lavoro molto più leggero. La domanda, quindi, diventa: come funzioneranno le cose, con Papa Francesco che non lavora (almeno non così tanto)?
Il Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin ha fatto capire alla stampa, che la macchina curiale si sta già preparando per compensare l’assenza del Papa dalla routine quotidiana [*]. Altri curiali anziani hanno detto più o meno la stessa cosa. Il Cardinale Fernando Filoni, attualmente in carica come Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ma meglio conosciuto dai tipi del Vaticano come il talentuoso diplomatico di lungo corso e un tempo Sostituto della Segreteria di Stato, fondamentalmente Capo di gabinetto papale, ha paragonato il governo della Chiesa oggi a quello di una famiglia il cui padre è in difficoltà e in cui i figli devono provvedere ai bisogni più urgenti.
C’è ben poco senza precedenti nella Chiesa, che dopotutto è un’istituzione vecchia di duemila anni, e in questo caso non c’è bisogno di guardare più indietro del pontificato di Papa San Giovanni Paolo II.
Gli ultimi anni di quel santo pontefice hanno visto un uomo indebolito e fragile, che un tempo era stato una dinamo assoluta, e una macchina curiale che continuava a prendere decisioni e a portare avanti la routine quotidiana. Infatti, dopo la morte di Papa Giovanni Paolo II, le sue ultime scelte persino sono state messe in discussione e le nomine episcopali pubblicate nel Bollettino del 2 aprile 2005, il giorno della sua morte, sono state avvolte nel sospetto: erano davvero decisioni papali?
Papa Benedetto XVI ha risolto il problema riconfermando quasi tutto quasi immediatamente. In seguito, avrebbe ovviato al problema della leadership assenteista rinunciando all’ufficio, quando si è reso conto che le sue forze lo stavano abbandonando.
Tracciare un parallelo con quei giorni è inevitabile, ma non esiste una simmetria perfetta in natura e in ogni caso ci sono diverse differenze importanti tra allora e oggi.
La prima differenza riguarda il metodo di governo.
Papa Francesco ha centralizzato tutte le decisioni. Ha spesso agito d’istinto, rapidamente e contrario alle consultazioni. In altri casi, è stato più cauto. Infatti, che abbia governato con più di 70 Motu proprio, cioè documenti che provengono direttamente dalla volontà papale, dimostra che il Papa non solo non aveva bisogno che le sue scelte fossero condivise, ma non ha nemmeno cercato di condividerle.
Papa Giovanni Paolo II, d’altra parte, ha governato in modo collegiale. Non tutte le sue aperture e intuizioni sono state amate e approvate dai suoi collaboratori. Sono avvenute discussioni intense. Hanno coinvolto i migliori amici e i più convinti sostenitori di Papa Giovanni Paolo II, ma – e questo è di fondamentale importanza – quegli amici e alleati erano veri consiglieri e consiglieri che spesso non condividevano la visione delle cose del Papa e non avevano paura di dirlo. Ad esempio, il Cardinale Joseph Ratzinger non è mai stato un grande fan degli incontri di pace ad Assisi, non per il tema o il dialogo tra le religioni, ma piuttosto per il sincretismo religioso che si rischiava di respirare. Quando Papa Giovanni Paolo II decise di chiedere perdono durante il Giubileo, un altro esempio, anche quella decisione fu discussa e contestata. Tuttavia, quei dibattiti portarono a spiegazioni piuttosto che a chiusure o esclusioni. Ad esempio, la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò un opuscolo sulle richieste di perdono, contestualizzandole e spiegandole. Alla fine, la discussione non verteva sul Papa. Riguardava la Chiesa. E ogni decisione del Papa doveva essere spiegata per mantenere l’unità della Chiesa, non per opporsi a chi si opponeva.
Papa Francesco ha fatto dell’inclusione radicale una delle bandiere del suo pontificato. Il suo “chi sono io per giudicare”, pronunciato al ritorno da Rio de Janeiro, dove era stato per la Giornata Mondiale della Gioventù, rappresentava le linee guida del pontificato. Radicalità inclusiva per i divorziati risposati – sui quali non c’è stata una chiara linea dottrinale – ma anche benedizioni per le coppie irregolari, sempre al confine tra dottrina e pratica, ma sempre, alla fine, lasciando fuori dal recinto chi segnalava le difficoltà delle scelte.
Così, la radicalità inclusiva per tutti diventa radicale esclusione quando ci si volta a guardare dentro la Chiesa stessa. Papa Francesco non ha mancato di bollare come “indietristi” coloro che non condividevano la sua visione, a volte senza preoccuparsi di andare a vedere le ragioni profonde delle loro posizioni, ma attribuendo a queste decisioni un significato più socio-politico che religioso. Questa radicale esclusione, unita a una forte centralizzazione, diventa un limite significativo di quest’ultima parte del pontificato di Papa Francesco.
Papa Francesco è quasi invisibile, non governa più se non per le questioni più urgenti e anzi, se guarirà, applicherà le sue priorità all’agenda della Chiesa. Ma nessuno può dire di poterlo aiutare a governare, perché qualsiasi possibile aiuto dato, potrebbe un giorno essere considerato un tradimento della volontà del sovrano.
Per un pontificato che negli ultimi anni si è basato sulla questione della “volontà papale”, anche per prendere decisioni controverse, ci troviamo ora in una situazione in cui la volontà papale non può essere completamente definita. Il Papa, che non ha mai voluto guardiani, si trova ora a dover accettare che chi monitora la sua salute a Santa Marta possa decidere chi entra nella sua stanza e chi no.
Nel frattempo, ci sono diverse questioni aperte, tutte da risolvere.
Si racconta di lettere in cui si chiede di accelerare le transizioni con scelte improvvise, di nominare nuovi capi commissione e di fornire nuovi punti di riferimento in questa difficile transizione. Queste lettere seguono gli input iniziali del Papa. Tuttavia, non si sa in che misura questi input siano stati ora accelerati dal Papa stesso.
Rispetto ai tempi di Papa Giovanni Paolo II, c’è incertezza nel governo perché nulla può essere attribuito al Papa. Ciò non significa che il Papa debba essere considerato incapace, e non è certo il momento di discutere di un’eventuale rinuncia del Papa.
Papa Francesco c’è, è lucido, e tra l’altro, un’eventuale rinuncia oggi sarebbe sottoposta al vaglio della storia: si tratta di una rinuncia volontaria o di una rinuncia dettata dalle circostanze? Se fosse il secondo caso, non sarebbe valida.
Fino a che punto possiamo vivere in questa situazione sospesa?
Fino a che punto i cardinali, ignari delle reali condizioni del Papa di cui non viene data tempestiva informazione, si sentiranno liberi di prendere decisioni che coinvolgono la Chiesa universale? E fino a che punto le decisioni successive saranno del Papa?
La questione del governo della Chiesa in questi tempi è cruciale. I cardinali esamineranno anche il modo in cui la Chiesa è stata governata quando un giorno si incontreranno per decidere sul 266° successore di Pietro.
Questo articolo nella nostra traduzione italiana è stato pubblicato dall’autore in inglese sul suo blog Monday Vatican [QUI].
[*] Il Cardinal Segretario di Stato Parolin sul Corriere della Sera: il Papa non ha mai smesso di governare la Chiesa – 29 marzo 2025 [QUI]
Papa Francesco: Card. Parolin, “riposa e non ha udienze”, ma “è ben collegato con la Chiesa e i fedeli” – 27 marzo 2025 [QUI]
La Cronistoria del ricovero del Santo Padre Francesco al Gemelli dal 14 febbraio 2025 e della convalescenza al Domus Sanctae Marthae dal 23 marzo 2025 [QUI].